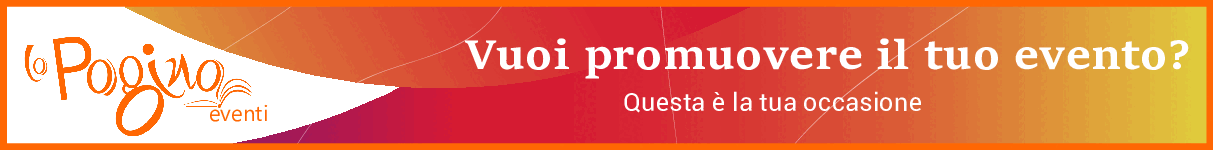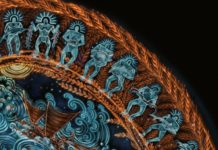Fino alla metà del secolo scorso, decennio più, decennio meno, i contadini umbri passavano “i primi caldi” a fare le fronne, cioè a raccogliere le foglie degli alberi per darle da mangiare alle vacche e agli altri animali erbivori. Tra aprile e maggio avevano falciato la biada, il trifoglio, l’erba medica e la lupinella e poi aspettato che il sole avesse svolto il suo compito, trasformandole col calore in fieno, insieme al lavoro di tutta la famiglia contadina nel rovesciarlo a mano con le forche affinché diventasse tutto secco in modo omogeneo. Fatto ciò, si portava il fieno nell’aia e con esso si costruiva il pagliaio, unico sistema allora noto per la conservazione del prezioso alimento per il bestiame durante tutto l’inverno e oltre (v. l’articolo “Il pagliaio” su La Pagina di aprile 2013).
Non essendoci ancora la mentalità dell’irrigazione, mancando a volte anche l’acqua e con il costo esorbitante delle pompe, si aspettava che la pioggia facesse il suo servizio gratis facendo ricrescere le erbe. Se non pioveva o pioveva poco, le erbe non ricrescevano e allora bisognava raccogliere le foglie degli alberi, incominciando da quelli maritati con le viti, per alimentare gli animali, specialmente le vacche da lavoro. Maritare una vite voleva dire piantarla alla base di un albero già grandicello, dove essa potesse arrampicarsi ed esserne poi sorretta.
Gli Etruschi sono stati i primi in Italia, oltre 3000 anni fa, a coltivare la vite a partire dalle varietà selvatiche e sembra che lo facessero fin dall’età del Bronzo, comunque almeno dal XII sec. a.C. Era una pianta che vedevano nel suo ambiente naturale, il bosco, dove avevano già imparato a raccoglierne i frutti, e la coltivarono poi così come la vedevano crescere spontaneamente.
La vite è un arbusto rampicante, una specie di liana.
Nel suo ambiente naturale, alle nostre latitudini, tende ad arrampicarsi su un albero per raggiungere il più possibile la luce (è molto eliofila). Non è però una specie parassita: la vite non interferisce con l’albero su cui s’aggrappa. Questa modalità di coltivazione etrusca è stata chiamata per secoli vite maritata.
La vite è come “sposata” all’albero a cui s’avvinghia.
Questa definizione non è d’epoca etrusca ma nacque più tardi, in epoca romana. L’immagine così evocativa della vite che abbraccia l’albero non rimase però confinata ai soli contesti agrari. Accese anche l’immaginazione di artisti e letterati, che le attribuirono diversi significati simbolici.
Dal I secolo d.C. comparve nella letteratura latina la metafora poetica della vite e dell’albero (soprattutto l’olmo) come simbolo dell’amore coniugale. La vite è “sposata” all’albero: da qui nacque il termine vitis maritae che usiamo ancora oggi (“vite maritata”). La vite maritata è rimasta nella cultura viticola italiana fino a quasi i nostri giorni, in tutti quei territori dove in antichità era arrivata la civiltà etrusca.
In quei tempi le viti erano allevate soprattutto su aceri campestri, ma anche pioppi, olmi, ulivi e alberi da frutto. In epoca storica più recente, l’olmo divenne la pianta preferita per tale accoppiamento, perché longeva – può raggiungere i 600 anni – e vigorosa. Poteva essere potata in modo drastico producendo legna e a primavera si ricopriva comunque di germogli pieni di foglie. Ai primi caldi, in mancanza di altro foraggio, le fronne (le fronde) venivano colte totalmente per l’alimentazione del bestiame, lasciando l’olmo completamente spoglio, come fosse inverno.
Questa immagine povera e spettrale somigliava all’aspetto della persona alla quale era stato promesso larvatamente un regalino che poi non gli era più stato dato per ignote ragioni.
Da ciò nacque il detto dialettale: M’honno fattu ormu, cioè ridotto senza niente come l’olmo.
Vittorio Grechi